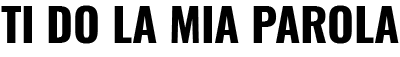Vivevo all’Esquilino da piccola. Il colle della Domus Aurea che confina con il Colosseo, i Fori, il Palatino. Allora quell’area era un vero parco archeologico: per gran parte un giardino senza cancelli, aperto a tutti dove si andava per giocare, raccogliere pinoli e nascondersi tra le rovine che nella fantasia dell’infanzia diventano le nostre case o le botteghe dove si fingeva di vendere e comprare sassi e lumachine.
Il lato opposto invece confinava con la Stazione Termini, e oltre la stazione con il quartiere di San Lorenzo che era stato bombardato dalle forze alleate nel luglio del 1943, poco prima della liberazione. Le 4.000 bombe sganciate provocarono 3.000 morti, 11.000 feriti e cumuli di macerie tra San Lorenzo e i quartieri limitrofi.
Anche l’Esquilino era stato danneggiato. Le bombe cadute qua e là sugli edifici avevano lasciato vuoti, mura spezzate, intonaci sfregiati da proiettili che ancora negli anni Sessanta non erano stati riparati.
Li ricordo come denti cariati, mostri, fantasmi spaventevoli che sbucavano all’improvviso tra i composti palazzi del quartiere Umbertino, dal gusto franco-piemontese costruiti nella utopica solidità borghese da età giolittiana.
Dunque ho avuto la fortuna di crescere tra gli antichi resti della Roma imperiale pieni di luce, ombra dei pini, muschi, colori dolci che fondevano il bianco latte del travertino e i rombi rossi delle mura reticolate. Raggiungevo a piedi quell’incanto che giustificava tutti i possibili viaggi da Grand Tour e che per me era un normale giardinetto dei giochi.
Ma le rovine della guerra invece, grigie e sporche, facevano paura. Uno degli edifici crollati per una buona metà era sede dell’Ufficio d’Igiene. Il posto dove venivamo vaccinati per malanni vari, il vaiolo ad esempio. E lì, l’immagine delle cicatrici del vaiolo che vedevo sul braccio degli adulti si sovrapponevano alle lacerazioni del muro, alle pareti crollate, ai buchi negli intonaci e poche cose mi sembravano allora così vicine all’orrore quanto quel dimezzato palazzo che nascondeva terribili e sfiguranti malattie e ricordava tutti i feroci racconti della guerra che chissà perché i vecchi amavano così tanto raccontare ai bambini.
Anche da adulta ho sempre avvertito una certa diffidenza nel passare accanto a quel rudere di Via Merulana, sebbene capitasse di rado perché da tempo mi ero trasferita altrove. Ma quella mutilazione, ormai consolidata e otturata nel cemento, mi faceva inevitabilmente tornare alla mente tutti i brutti pensieri.
Ora non esiste più. Completamente restaurato nel 2018 l’ex Ufficio d’Igiene di via Merulana 121, è diventato sede della fondazione privata Elena e Claudio Cerasi, centro di cultura e d’arte che conserva in collezione permanente decine di opere (molte bellissime) degli anni Venti e Trenta. Donghi, Francalancia, Capogrossi ancora figurativo… Dipinti anteguerra con ritratti di composte signore, eleganti scene balneari, metafisiche immagini di città perfette, di donne e uomini perfetti.
E mentre la radicale ricostruzione della Fondazione cancella dopo 75 anni gli ultimi brandelli di distruzione lasciati conflitto mondiale, anche le rovine sontuose della Roma archeologica sono in qualche modo state spazzate via dalla vita quotidiana del quartiere. Cancelli, reti, comitive, tour operator, finti gladiatori, banchetti di souvenirs, file di torpedoni turistici che erigono muri a fianco della via sacra e il flusso ininterrotto di una folla multirazziale vomitato ad ogni istante dall’uscita della metropolitana.
O almeno così era, fino ai giorni della pandemia. Questi giorni in cui mi si chiede di riflettere sulla parola ROVINE. E nell’ambiguità che questo termine mi suscita arrivano dalla memoria immagini, e pensieri impressi nel mio tempo, come un susseguirsi di sensazioni contraddittorie che può ben cominciare dalla foto che segue.