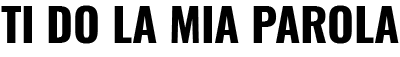Premessa
Per questa riflessione sulle ‘rovine’ ho scomodato uno dei più grandi incisori italiani, certamente il più conosciuto al mondo, Giovanni Battista Piranesi. Con lui ho deciso di percorrere questo viaggio, per immagini e musica, perché imprescindibile è il suo lavoro, dato il contesto, e perché è giusto tributargli questo onore, a trecento anni esatti dalla sua nascita.
Nato il 4 di ottobre del 1720, Piranesi (veneziano di natali ma romano di adozione) immortalò con le sue lastre le ‘rovine’ del grande impero romano che ancora nel ‘700 si potevano ammirare, in tutta la loro maestosa e romantica bellezza, a Roma e in Campania.
Da allora numerosi eventi, per lo più umani, hanno causato la perdita di molti di queste testimonianze che oggi possiamo solo rivedere ed ammirare nelle stampe del passato immedesimandoci nello sguardo di chi le ha eternate per noi.
In questo lento intercedere alla scoperta dei significati più reconditi delle rovine che ciclicamente, ma non inspiegabilmente, tornano nelle mie riflessioni, gli scritti di Marc Augè, uno dei più importanti antropologi esistenti, saranno invece la mia bussola.
Dunque, cosa sono realmente quelle che oggi ci accingiamo a definire, con spirito quasi malinconico, ‘rovine’? cosa ci spinge ad ammirarle silenti quali fasti irripetibili dei tempi andati e proteggerle e tutelarle dal passare del tempo? Cosa ci obbliga moralmente ad erigerle a beni culturali e valorizzarle con il massimo degli sforzi?
Parliamone senza infingimenti: le rovine altro non sono che resti di opere che raccontano il loro tempo, ma non possono né potranno mai, in alcun modo, raccontarlo in modo esauriente.
Coloro che le contemplano oggi, quale che sia la loro erudizione, non avranno mai lo sguardo di chi le vide per la prima volta. Esiste dunque un vuoto, uno scarto tra la percezione scomparsa e la percezione attuale e questo vuoto altro non è che l’effetto dell’epoca in cui viviamo caratterizzata, ahinoi, da istantaneità, velocità di trasmissione di messaggi, sensazioni, informazioni, e financo emozioni. Siamo cioè dinnanzi alla messa al presente – la présentification filosofica – di tutti i fenomeni: il culto del presente perpetuo ha smarrito la dimensione cumulativa della storia, quella dove al tempo si aggiungeva tempo, dando luogo al concetto di passato.
A cosa serve dunque questa necessità ricorrente di recuperare dal passato e riportare al presente, se il poi il presente stesso ci passa accanto senza destare alcuna riflessione o, peggio, indignazione?
Guardiamoci attorno: per quelle tutelate, restaurate e valorizzate si può esprimere contemplazione, ovvero si può tentare di fare un’esperienza del tempo puro, non databile, per riprendere coscienza della storia; per tutte le altre invece non possiamo più parlare di rovine, ma di macerie, sempre rimovibili che, ove conviene lasciano il posto alla ricostruzione.
E se fosse solo questo non sarebbe un dramma. Purtroppo c’è dell’altro e non possiamo far finta di nulla, anche se ci fa comodo dalla nostra posizione privilegiata: la nostra epoca “non ha più il tempo” di produrre ‘rovine’, monumenti della memoria; la nostra epoca ha ben altre capacità: quelle di accumulare macerie, detriti, avanzi, distruzioni, frantumi, rottami, abbandoni.
La riflessione dunque ci deve portare oltre. Anche oltre il visibile.
Da una parte abbiamo un patrimonio artistico, culturale e naturalistico che si presenta come un oggetto di consumo più o meno decontestualizzato, di vanto in talune occasioni, il cui vero contesto però è il mondo della circolazione planetaria. In questa realtà, oramai compromessa, le ‘rovine’ forse sono l’ultimo segno di vitalità perché non balbettano il proprio passato scadendo nel pittoresco, nella farsa o nel simulacro. Esse ridonano il senso del tempo poiché sono osservabili come presenze attuali, non volgarizzabili dallo storicismo di consumo; esse conservano l’indeterminabilità e il mistero.
La loro bellezza dipende dalla loro inafferrabilità.
Dall’altra parte però abbiamo anche le ‘rovine’ accumulate dalla storia recente, spesso dimenticate, o volutamente trascurate, lontane dal turismo massificato, che però non assomigliano a quelle del passato. Vi è indubbiamente un grande scarto fra il tempo storico della distruzione, che rivela la follia del mondo contemporaneo (Aleppo, Kabul, Beirut, Damasco), e il tempo puro, quello in rovina, “che ha perduto la storia o che la storia ha perduto”.
Ma la follia della storia è una follia ripetitiva.
Gli errori e gli orrori si ripetono, e si ripeteranno
Non è un caso che la parola ‘rovina’ deriva dal latino ruĕre, «precipitare»: le rovine sono, e sempre saranno, nient’altro che lo specchio di un genere, quello umano, che ha lasciato che divenissero tali, che “precipitassero” cioè nell’oblio: tutto è figlio della sua inettitudine alla convivenza, della sua instabile prepotenza, della sua ingiustificabile necessità di cancellare quello che non vuole accettare con il risultato che la nostra epoca potrà produrre oramai solo macerie e mai più rovine.
E il mondo finirà, prima o poi, senza più storia da tramandare.
Del presente e del passato prossimo non ci sarà che dimenticanza.
Ecco perché dovremmo essere grati a Piranesi, e con lui a Pannini, Clérisseau o Hubert Robert. Al loro sguardo, ai loro ricordi, alle loro emozioni.
Quei paesaggi, ove nessuno metterà mai più piede, erano forse le ultime sublimi espressioni dell’utopia umana che potevano sfuggire, e sottrarsi, anche alla storia.
Le idee che le rovine suscitano in me sono grandiose. Tutto si annienta, tutto perisce, tutto passa. Soltanto il mondo resta. Soltanto il tempo dura [...]. Una corrente irresistibile trascina le nazioni le une sulle altre in fondo ad un abisso comune; io solo pretendo arrestarmi sul ciglio e fendere il flusso che scorre intorno a me! - Denis Diderot