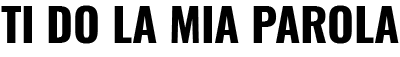Federico Triulzi, Invisibile, 2020
Christopher R. Hallpike ha rilevato che nel pensiero primitivo lo spazio è stato ordinato secondo sottili principi topologici, il cui motivo ispiratore è da ricercare nelle profondità affettive e simboliche di «un ordine cosmico, nel quale quello sociale del gruppo si rispecchia con trepidazione» (Hallpike, 1984). Questo nucleo più vitale dell’esperienza si rivela nella quotidianità di una relazione affettiva e immaginativa con il mondo. Eugenio Turri indica un’altra relazione: quella tra “visibile” e “non visibile” nel saggio Il paesaggio e il silenzio. Non sono visibili le mappe mentali, così come i confini tra gli spazi vissuti, eppure orientano la nostra esperienza, consentendoci di attribuire posizioni e valori al nostro intorno. È dalla capacità delle comunità di valorizzare il non visibile, integrandolo nella cartografia del proprio immaginario, che dipende la costruzione culturale del paesaggio. Ad esempio, le dimensioni del “locale” e del “globale” assumono un senso in base a percezioni non sempre oggettive, ma connesse alla nostra capacità di instaurare un rapporto con ciò che non si vede e di sentire ciò che non è “in presenza”. Anche ciò che è distante o assente viene integrato in una totalità che deve essere compresa. In questo spazio che si riempie di presenza e di esperienza, il non visibile è condizione necessaria per spazializzare, per fare da contrappunto a ciò che si mostra: «Vediamo il paesaggio che desideriamo vedere, che non disturba la nostra idea di paesaggio. Quindi c’è tutta una serie di cose che restano invisibili, anche se fanno parte concretamente, organicamente del territorio di cui cerchiamo il riflesso. Ma i segni visibili o invisibili nel paesaggio che importano per gli abitanti di una certa zona sono sempre celati nella mente degli abitanti, nel loro sentimento dello spazio, del tempo, della storia» (Turri, 2004).
Segni celati nella mente degli abitanti, segni che rimandano al vissuto, alle fantasie, alle componenti storiche e memoriali, ad una dimensione interiore, o esperita. Questo paesaggio si costituisce come luogo dell’intersoggettività, proprio a partire da ciò che non si vede, ma è rappresentabile, tramite simboli condivisi, o al di là di essi, come nei muri delle città che l’archivio fotografico di Federico Triulzi illumina in modo sottile. I muri che ci racconta questo lavoro rendono visibile qualcosa che per stessa definizione (della frase o del disegno che vi leggiamo) non lo è. In fondo nella sostanza stessa del muro, sembrano dirci queste immagini, è presente la doppia natura di limite e soglia, di recinto e di pagina. In esso convivono l’esclusione e l’espressione. Ogni contenuto che vi si manifesta non fa altro che dire la sua possibilità e impossibilità, in un ossimoro. Nel paesaggio urbano si dispiega l’invisibile proprio mentre si mostra. Di quanti tipi di invisibilità ci parla questo linguaggio silente e urlato, questa città che Federico attraversa cogliendone i cambiamenti, le più piccole espressioni, le sue immagini dette e quelle non volute? Dell’invisibilità della fede, che si esprime nelle richieste degli ex voto, di quella filosofica di un messaggio che si costruisce nelle associazioni tra forme e messaggi di istanti diversi, di quella sociale, della protesta, del libero pensiero che si nasconde mentre si rivela. L’invisibilità cui si riferiscono frasi, poesie, parole o l’invisibilità delle persone che hanno lasciato quel segno; l’invisibilità di uno sguardo che vede entrambe e disegna percorsi nuovi attraversando la soglia semantica dei loro rimandi. Queste immagini percorrono la storia di una sedimentazione urbana in cui ciò che non esiste si palesa: l’invisibile visibile (espresso), che al tempo stesso, citandosi, si contraddice. il paesaggio che ci mostra Federico è un territorio frammentato che non chiede di essere ricomposto per fare sistema, perché non c’è, se non nella notte della poesia involontaria e del gesto fortuito, nel vento che strappa, allontana e distrugge per ridisegnare nuove vicinanze, nella voce singola e nella singola preghiera. Tornando in ciascuno dei luoghi attraversati non ritroveremo quel paesaggio divenuto familiare, tutto ciò che è visibile è destinato a non esserlo agli occhi dell’altro o semplicemente il giorno dopo, agli occhi della storia. L’invisibile si muove e per questo permane al di là del nostro sguardo, segnando la mappa della nostra sensazione di città, tracciando le sembianze di ciò che è ad un tempo caso e ideologia.
Il limite tra identità e alterità