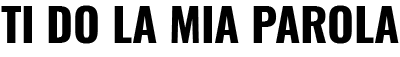Pochi giorni fa ho ricevuto una mail di Stefano, un amico con il quale non mi sentivo da più di dieci anni. Poche parole, un allegato, un abbraccio.
Il testo che mi inviava era un piccolo estratto di Walter Benjamin dal titolo “Scavare e ricordare”.
Mi son tornate alla memoria le lunghe chiacchierate in cui fantasticavo sul mio futuro. Stefano era sempre lì ad ascoltare le ipotesi più assurde.
Fare l’archeologo sembrava la fissa del momento. Tra tutte forse, quella in cui credevo di più. Ed è così che lo sono diventato davvero.
Lo scavo nel mio lavoro è la parte fondamentale: l’archeologia si basa su interventi di vero e proprio smontaggio del terreno che sta sotto i nostri piedi. Nell’immaginario collettivo l’archeologo trova oggetti singoli, indipendenti, con vita propria.
Niente di tutto questo.
L’archeologo è ben conscio del fatto che quel singolo reperto da solo è perduto. È senza identità, non ha ricordi, non ha ragione d’esistere.
Non ha vita fuori dal contesto in cui si trova. Privo della terra che per secoli l’ha coccolato, educato, schiacciato, plasmato. Non ha memoria.
Persino un sasso ha migliaia di interazioni che ne costituiscono il passato e lo rendono tale. È davvero così inanimato come lo definiamo? O anch’esso ha una sua memoria?
Da bambino amavo ascoltare mia nonna materna. Perdevo il mio sguardo lungo i solchi profondi che scavavano il suo viso. Mi immergevo nel turbinio di racconti della sua giovinezza, la sua voce decisa e tremolante portava alla memoria immagini felici e spensierate.
Quei singoli ricordi non erano un passaggio obbligato, non un semplice collegamento tra le migliaia di pensieri che quotidianamente affiorano tra gli strati della mente. Erano qualcosa di più grande. Erano un contesto più ampio, un luogo in cui “chi ricerca se ne impadronisce”. Un ambiente quasi mistico in cui il ricordo era frutto di quegli strati indagati per individuarlo.
Le sue radici diventavano le mie.